Comunità Energetiche Rinnovabili: Un’Analisi Approfondita tra Aspetti Tecnici, Economici e Sociali

Il panorama energetico europeo è in piena trasformazione, con un’attenzione crescente al ruolo dei consumatori finali, che da semplici fruitori diventano attori attivi nella generazione, flessibilità e definizione delle politiche energetiche future.
In questo contesto, il documento di ricerca (scaricabile a fondo pagina) “Comunità energetiche: gli strumenti della ricerca per analisi tecniche, economiche e sociali” a cura del Gruppo di Sistemi Elettrici per l’Energia del Politecnico di Milano, del Sustainable Energy Laboratory dell’Università degli Studi di Trento e del Laboratorio Energia e Ambiente di Piacenza (LEAP), offre un’analisi critica e dettagliata delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (CACER) in Italia, confrontandole anche con modelli europei e prospettando scenari futuri.
Il Nuovo Ruolo del Consumatore e il Contesto Regolatorio
La pubblicazione del Clean Energy for all Europeans Package ha segnato un punto di svolta, conferendo ai clienti finali la possibilità di partecipare attivamente al sistema energetico.
Le direttive europee 2018/2001/UE (RED II) e 2019/944/UE (IEM) definiscono il quadro per la partecipazione individuale e collettiva, introducendo schemi di autoconsumo (anche collettivo) e le comunità energetiche.
Le CER nascono con lo scopo principale di offrire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari. Il Clean Energy Package promuove principi chiave come l’efficienza energetica, l’aumento delle fonti rinnovabili, una migliore governance, maggiori diritti per i consumatori e un mercato elettrico più efficiente.
Definizione e Obiettivi delle Comunità Energetiche
Le CER rispondono all’obiettivo di incrementare l’uso di energie rinnovabili e i diritti dei consumatori, promuovendo progetti di autoconsumo rinnovabile e incentivando l’installazione di impianti FER tramite nuove modalità di condivisione dell’energia.
Queste iniziative mirano anche a coinvolgere gli utenti nei benefici economici e ambientali dei progetti rinnovabili e a facilitare la partecipazione dei piccoli utenti al mercato. Un aspetto cruciale è la possibilità di rendere l’energia accessibile a prezzi contenuti anche per utenti vulnerabili, rendendo le CER un potenziale strumento per combattere la povertà energetica.
Il Quadro Normativo Italiano: Dalla Fase Pilota alla Trasposizione Finale
L’implementazione italiana della direttiva RED II, che ha portato alla definizione delle CACER (tra cui spiccano le CER), è avvenuta in due fasi principali:
- Fase Pilota: questa fase iniziale ha permesso di testare le potenzialità e le criticità delle CER su porzioni limitate del territorio, corrispondenti all’area servita da una cabina secondaria (CS). La taglia degli impianti era limitata a 200 kW e l’incentivo si basava sulla condivisione di energia, calcolata orariamente. Le prime esperienze hanno visto la partecipazione di amministrazioni locali e enti di promozione sociale, focalizzandosi non solo sull’autoconsumo ma anche sulla sensibilizzazione ambientale e sul supporto a utenti vulnerabili. Esempi includono la CER di Magliano Alpi e la CER solidale di Napoli Est.
- Trasposizione Finale: in questa fase, il perimetro di incentivazione per l’energia condivisa si è esteso fino alla cabina primaria (CP), ampliando significativamente l’area potenziale delle CER. La taglia massima del singolo impianto FER è stata elevata a 1 MW. Sono state definite tre principali Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER): il gruppo di autoconsumatori collettivi (AUC) (stesso edificio), la Comunità di Energia Rinnovabile (CER) (più utenti nella stessa porzione di rete) e l’autoconsumatore individuale a distanza (stessa porzione di rete per un singolo utente con più punti di connessione). La remunerazione dell’energia condivisa prevede una valorizzazione da parte dell’ARERA (basata sui costi di rete evitati) e un’incentivazione stabilita dal MASE (tariffa incentivante premio o TIP), che si aggiungono ai ricavi per l’immissione in rete. L’incentivo MASE varia in base alla taglia dell’impianto e alla zona geografica.
Analisi Tecnico-Economica delle Configurazioni di Autoconsumo
Il documento presenta analisi di casi studio per le tre tipologie di CACER.
- Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente (AUC): un esempio condominiale con un impianto fotovoltaico da 20 kW ha mostrato un potenziale risparmio sulla bolletta elettrica e un tempo di ritorno dell’investimento di 6-7 anni, considerando anche detrazioni fiscali.
- Comunità di energia rinnovabile (CER): una CER con 200 kW di fotovoltaico e 180 utenti (prevalentemente domestici) ha evidenziato un elevato livello di condivisione (58%) e un rientro dell’investimento in 7-8 anni.
- Autoconsumatore individuale a distanza: un caso di una PMI con un impianto fotovoltaico da 1 MW a terra ha mostrato un’alta quota di energia condivisa (78%), ma la normativa prevede che gli incentivi per le imprese siano limitati al 55% dell’energia immessa, con la restante parte destinata ad altre utenze.
Se vuoi iniziare a lavorare nell’ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili, dai un’occhiata al corso professionale di 8 ore sulle CACER, nel quale vengono affrontati tutti gli aspetti delle CER, da quelli tecnici e quelli legali e fiscali.
Confronto con i Modelli Europei
A livello europeo, l’implementazione del modello CER varia significativamente. Si distinguono principalmente due modelli di condivisione dell’energia.
- Modello virtuale: il beneficio economico per i membri della CER non si riflette direttamente in bolletta, ma tramite un incentivo gestito dalla CER e distribuito ai membri (ad esempio, Italia).
- Modello fisico: i membri beneficiano direttamente in bolletta della riduzione dell’energia commercializzata internamente alla comunità, valorizzata a un prezzo specifico (ad esempio, Portogallo e Spagna).
Germania e Paesi Bassi incentivano principalmente l’immissione in rete senza prevedere incentivi specifici per la condivisione. L’efficacia e l’efficienza dei diversi schemi incentivanti europei sono state analizzate, evidenziando come il modello italiano offra un buon compromesso tra i due aspetti.
Ottimizzazione dei Ricavi e Redistribuzione degli Incentivi
La presenza di asset flessibili (accumuli, carichi modulabili) offre alle CER la possibilità di ottimizzare la gestione per massimizzare i ricavi. Tecniche di ottimizzazione distribuita possono conciliare il coordinamento della comunità con le esigenze di privacy e autonomia dei singoli membri.
Sono stati studiati diversi algoritmi di redistribuzione dei ricavi, basati su criteri come il contributo all’investimento, l’incremento dell’energia condivisa e la vulnerabilità economica. Le CER solidali possono utilizzare questi algoritmi per mitigare la povertà energetica, redistribuendo i benefici economici verso gli utenti più fragili.
Mappatura della Povertà Energetica
Il documento sottolinea l’importanza di mappare il rischio di povertà energetica per indirizzare interventi mirati. Uno studio del Politecnico di Milano ha sviluppato indici economici (basati su reddito e spese per beni durevoli) ed energetici (basati sulla prestazione energetica degli edifici) a livello comunale per identificare le aree più a rischio.
La “Soglia del 55%” e il Ruolo delle Aziende
La normativa italiana prevede che, qualora l’energia condivisa superi il 55% dell’energia immessa, la quota eccedentaria di ricavi della CER sia destinata ai consumatori diversi dalle imprese. Questo meccanismo mira a proteggere i membri passivi delle CER.
Le aziende possono svolgere un ruolo di “produttori terzi” e referenti delle CER, promuovendo la nascita di comunità “chiavi in mano”. Tuttavia, possono sorgere conflitti di interesse tra l’azienda (che mira a massimizzare i propri ricavi) e i residenti (che potrebbero beneficiare di una maggiore redistribuzione).
Lo statuto della CER riveste un ruolo fondamentale nello stabilire meccanismi chiari di redistribuzione dei ricavi.
Impatto delle Comunità Energetiche sulla Rete Elettrica
Uno studio del Politecnico di Milano ha analizzato l’impatto delle CER sulla rete elettrica di distribuzione.
L’aumento della penetrazione energetica delle CER può comportare un incremento delle perdite di rete, soprattutto in contesti rurali e con pochi grandi generatori. Tuttavia, in contesti metropolitani, l’alta densità di carico può far sì che la generazione distribuita riduca il carico nodale e i flussi energetici sulla rete di distribuzione.
Lo sviluppo di nuove rinnovabili secondo i criteri delle CER risulta meno impattante sulle infrastrutture di rete rispetto a uno sviluppo non coordinato.
Le Prime Esperienze: Le Università in Prima Linea
Nonostante il potenziale, le CER realizzate in Italia sono ancora poche, a causa di fattori legislativi e tecnici. Alcune università, tra cui il Politecnico di Milano, si sono attivate per favorire la realizzazione di questi progetti.
Il Politecnico di Milano è coinvolto nella realizzazione di tre CER nei quartieri di Bovisa, Niguarda-Affori e Città Studi, con l’installazione prevista di circa 5625 kW di impianti fotovoltaici, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico diurno di quasi 1000 famiglie.
Le cinque CER promosse a Milano hanno dato vita all’associazione CER.ca.MI Solidale, un Ente del Terzo Settore con obiettivi prevalentemente sociali, che prevede di utilizzare i ricavi per progetti di mitigazione della povertà energetica e iniziative locali.
Prospettive Future: Dispacciamento e Community PPA
Nel futuro, le CER potrebbero evolvere verso la fornitura di servizi di flessibilità e ancillari alla rete elettrica. Il quadro normativo e di mercato si sta evolvendo in questa direzione.
Un’altra auspicabile evoluzione è verso un modello di Community Power Purchase Agreement (PPA), che permetterebbe di decarbonizzare la domanda residua tramite contratti di fornitura di energia rinnovabile a prezzi concordati, superando i limiti dell’autoconsumo locale, soprattutto in contesti urbani densamente popolati.
Conclusioni
Il documento evidenzia la complessità e le molteplici sfaccettature delle comunità energetiche, sottolineando il loro potenziale come strumento per la decarbonizzazione, la lotta alla povertà energetica e lo sviluppo di un’economia sostenibile legata ai territori.
Sebbene il quadro normativo sia ancora in evoluzione, le CER rappresentano un’opportunità significativa per rendere gli utenti protagonisti delle scelte energetiche future. La collaborazione tra cittadini, imprese, enti pubblici e università sarà fondamentale per concretizzare appieno il potenziale di questo modello.


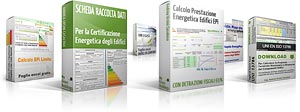

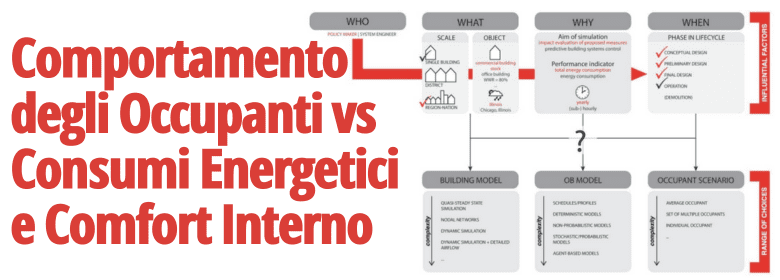



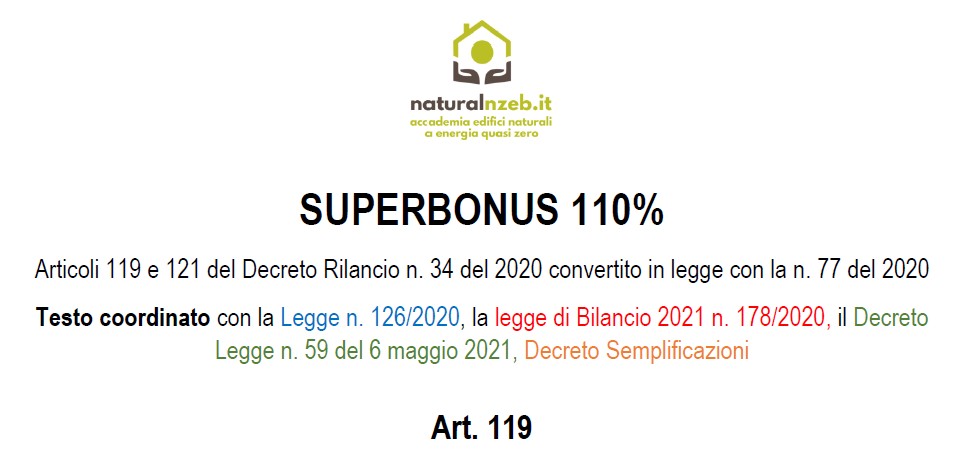

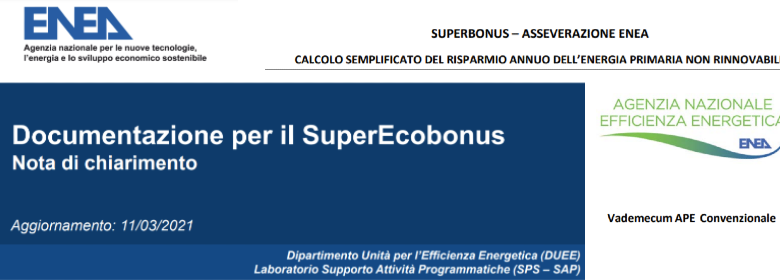


Risposte